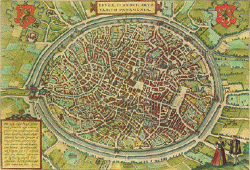Capita sempre nella vita di ritrovarsi a scegliere fra quantità e qualità (più amici senza guardare troppo per il sottile, meno amici ma di classe, meno soldi, ma più felicità etc.). La televisione italiana da anni ha scelto la strada della quantità. I più abbondano: più programmi, più conduttori, più pubblicità, più telegiornali.
La questione è annosa: cosa c‘è di reale nei reality e, molto di più, che cos‘è un reality? Non è certo affare di poche righe, come quelle che abbiamo qui sotto, disquisire su come inserisca la parola reality nell’idea stessa di realtà o falsità televisiva. Prendiamola alla larga, molto alla larga. Capita ancora oggi di dire, specie se si amano i termini desueti, ad un amico messo in crisi dalle sue stesse ardite supposizioni in merito alla fedeltà della sua fidanzata: “ma cosa vai a pensare, non siamo mica in un romanzo”. Il senso di questa frase è di facile comprensione, ma ha forse un portato culturale maggiore di quello che possiamo immaginare. Ci dice: la realtà non è quella incantata dei romanzi dove per romanzo si intende, per antonomasia, quello popolare ottocentesco e per realtà romanzesca ci si riferisce a un contenuto stereotipato di eroi, eroine, palazzi, maghi e avventure. Non è questione da poco: Franco Moretti, in un bel saggio dal titolo “Il secolo serio” inserito nel volume La cultura del romanzo da lui curato, riprende due termini Roland Barthes apparentemente astrusi: ’funzioni cardinali‘ e ’catalisi‘. Niente di più chiaro invece: le funzioni cardinali sono i nodi che determinano gli eventi di un romanzo, le catalisi sono tutti gli episodi definibili come ’riempitivi‘. Nota Moretti che il romanzo delle origini abbonda di nodi, tutta una successione di eventi epocali per lo spiegarsi della storia (X naufraga, si ritrova senza cibo, incontra una tribù di selvaggi; oppure X rivela il suo amore per Y, ma scopre che Y è sua sorella, Z imprigiona Y etc.). Poi il romanzo ’borghesE’ inizia a dare sempre più spazio alle catalisi, ai riempitivi che scandiscono una realtà non determinante ai fini della storia (descrizione di un pranzo di X e Y, pensieri e riflessioni di X dopo una cena dalle zie). Insomma, si indugia. Inutile dire che indugio non vuol dire noia, ma al contrario l’inizio del grande romanzo moderno: siamo più interessati al mondo che circonda Emma Bovary che ai suoi effettivi tradimenti (solo due in fondo, sciocchezze) e molto più ansiosi di scoprire il percorso interiore di Raskolnikov che di saper se verrà scoperto nel suo delitto. La narrazione quindi si compone sempre più di indugi, episodi apparentemente secondari, piccoli eventi (che giustamente ricordano a Moretti le composizioni dei quadri di Vermeer). Questo non succede nella letteratura di massa, o di largo consumo, dove invece abbondano i tradimenti, le passioni, gli svelamenti, financo gli omicidi. Qui, state pur certi che se ci si focalizza su un anello questo sarà la prova di un infedeltà e se passa un brutto ceffo per strada è probabile che abbia un coltello o una pistola sotto il cappotto. Ecco allora, la consolazione: “non siamo mica in un romanzo”. Memore di questa tradizione era anche la produzione fiction televisiva. Le telenovelas, i serial ma anche i rotocalchi rosa abbondavano di ’funzioni cardinali‘: quello ha tradito quell’altra, lei è incinta o forse no, quell’altro è il vero padre di quest‘altro; poco importava che si trattasse di narrazioni svoltesi nella finzione (telenovelas) o nella realtà (programmi di gossip).E poco importava, ovviamente, dei travagli interiori, degli indugi privati dei personaggi. Tutto questo costruiva una realtà ’magica‘ cara agli studiosi della ’uses and gratification theory‘ in cui la casalinga di Voghera e il bracciante lucano potessero identificarsi, uscendo dalla loro routine quotidiana. Il reality non cambia le carte in tavola, le inverte. È l’indugio,l’elemento intimo e privato, a invadere per intero la scena narrativa. Niente di quello che succede in un reality può davvero configurarsi come un nodo, come una funzione cardinale e la cosa salta agli occhi. Cosa può succedere ad uno qualunque dei personaggi all’interno di un reality che possa risultare un nodo, un momento cardinale nella sua vita: non si hanno svelamenti (non si hanno notizie nei Grandi Fratello e simili di agnizioni: nessuna madre perduta, nessun ricongiungimento familiare), non si hanno gravidanze, omicidi, rapimenti. Non succede in ore e ore di riprese nulla di quello che può succedere in una pagina del Conte di Montecristo o in una puntata di Beautiful. Resta però qualcosa di quest‘ultimi: la particolarità dello sfondo (isole deserte, case hi-tech) e la dimensione irreale dei personaggi (uomini e donne famose o quasi, ragazzi/e ex comuni, ora nobilitati dal programma, donne particolarmente belle e stupide o uomini eccezionalmente brutti e intelligenti).

È la narrazione che si è via via resa evanescente, perdendo anche le basi stesse del racconto. Cosa è rimasto, nell’Isola dei famosi, dell’idea del naufragio, se non che i naufraghi si trovano su un bellissimo atollo caraibico? La differenza fra una fiction e un reality, o meglio, una delle differenze, è che il reality è protonarrativo rispetto alla fiction: non vi è nessuna storia complessa, ma la combinazione di situazioni. Eco scrive nelle sue Postille al nome della Rosa che il romanzo nasceva dal suo desiderio inconscio di vedere dei preti o dei monaci uccisi in un convento. Ecco la forma protonarrativa di un possibile reality: dei monaci in un convento, magari monaci famosi, ma niente morti per carità. Stevenson pensava, un secolo prima, per far dormire il figlio irrequieto, a un’isola dove in molti cercavano un tesoro nascosto. Ecco l’idea principe di molti reality su cui gli eredi dello scrittore scozzese potrebbero chiedere delle royalties. Stevenson ed Eco hanno avuto la perseveranza di continuare questa forma primigenia e costruirne una fiction, un romanzo. Alla base c‘era un momento embrionale che accomuna tutti, scrittori, spettatori, lettori, ma che è cosa ben diversa dal costruire una storia: è in questo senso che siamo tutti ideatori di reality e in pochi scrittori di romanzi. Chi non ha pensato, almeno una volta, nella sua vita, guardando certe vallette inebetite e succinte o certi calciatori che facevano e pensavano tutto quello che faceva e pensava il mister e nonostante questo, o proprio grazie a questo, guadagnavano notevoli quantità di denaro, chi non ha pensato che queste persone sarebbero state bene, per un periodo, per carità non troppo lungo, in un’isola deserta senza cibo e senza tetto? Quanti fra noi, guardando il compagno tutti 10 con occhiali e brufoli e la bionda, bellissima ragazza un po‘ oca, ma molto cool della classe accanto, non si è detto: ’ti immagini metterli assieme nella stessa camera per un mesE’. Ognuno di noi aveva già inventato il reality che inevitabilmente non è meno o più reale del resto della televisione, semplicemente non si basa su una scaletta, su un copione, su una sceneggiatura; esso salta la dimensione discorsiva, l’affinamento degli spazi, dei caratteri e si attacca direttamente alla forma protonarrativa che appartiene già al pensiero di tutti coloro che sono troppo impegnati in altro per fare televisione anziché guardarla.
La dimensione discorsiva si blocca in questa narratività aurorale e i personaggi e il loro sfondo si immergono in un tempo dilatato (catalisi, indugio) dove è persa la possibilità di approfondimento psicologico, dove i singoli gesti e i singoli atti non ricostruiscono le esistenze dei personaggi, come invece avveniva nel grande romanzo borghese di cui parla Moretti. Resta però lo strano effetto di una low fi-reality (per citare un bel saggio di Demaria, Grosso, Spaziante) dove, come in un romanzo che metta insieme le fortezze e gli intrighi di Dumas, le pie fanciulle e i principi cattivi di Walpole con i tempi e le descrizioni di Kafka e di Dostoevskij, si inseriscono fra personaggi famosi e isole di sogno le telecamere fisse di Warhol o di Godard. Non la ipereality delle telenovelas, atte a soddisfare i bisogni delle casalinghe insoddisfatte, ma una travolgente iporeality. Cosicché, oggi, all’amico che, questa volta, appare troppo sicuro, nonostante certi indizi, della fedeltà della sua fidanzata, possiamo dire: “Ehi, stai attento, bello, non siamo mica in un reality show.”